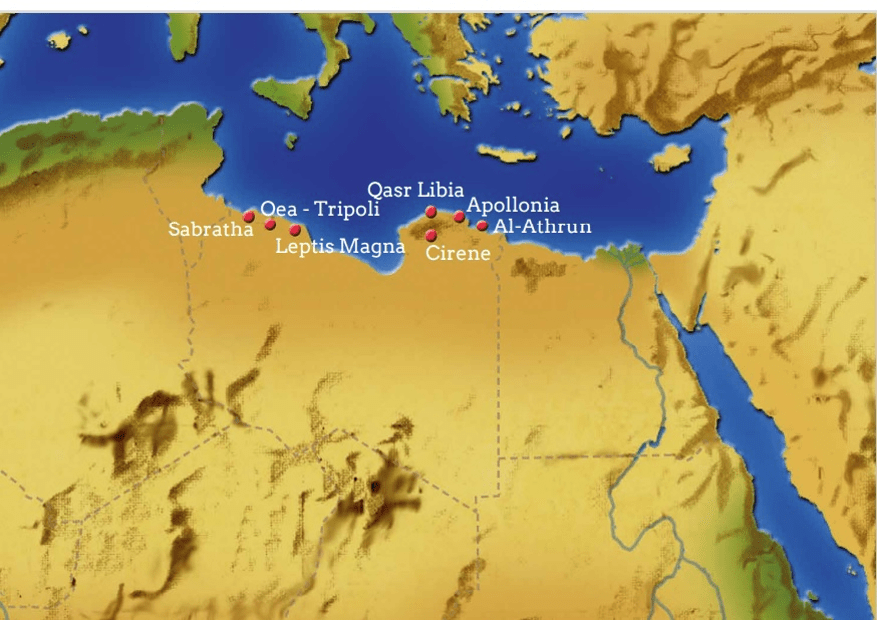Un’altra mattina di sole stava per illuminare la piana. Le vette tutt’intorno si stavano tingendo di rosa e le nevi che dimoravano eterne su quelle cime risplendevano nell’aria cristallina del primo mattino. Il clima era ancora fresco in questo inizio di primavera e l’altezza dei monti impediva al sole di uscire dalla linea dell’orizzonte al mattino presto. Il cielo si accendeva guardando verso nord-est e la grande montagna che separava quella terra amata dagli dei da quella dei vicini Veragri e Seduni sfolgorava catturando i primi raggi donati dal dio Belenos.
La piccola Lythia amava molto quel momento iniziale della giornata. A differenza degli altri bimbi del villaggio, lei non faticava affatto ad alzarsi presto; non vedeva l’ora di uscire per dare il “buongiorno” agli animali, sgranchirsi le gambe dopo la notte, respirare a pieni polmoni l’aria frizzante dei suoi monti.
E, soprattutto, amava andare a scuola ad ascoltare le storie che la saggia e sapiente Licamara, anziana del villaggio, nonché sua nonna, raccontava quotidianamente ai piccoli della tribù.

Licamara era la mamma di suo padre, il valoroso Catumaro, grande capo e coraggioso guerriero. Ma anche ardito esploratore di quelle grandi montagne, di cui sin da giovane percorreva ogni passo, ogni colle, ogni pertugio.

Catumaro conosceva ogni angolo di quella terra di roccia, e con saggezza governava quello che da tutti era riconosciuto come territorio cardine per gli scambi commerciali tra le grandi vette dell’Ovest e del Nord, tra i Salassi della terra del sud, fino al grande fiume Bodinco, i Veragri e i Seduni delle terre del nord, oltre l’importante passo sacro al dio Penn, protettore delle vette inviolate, e gli Allobrogi delle terre dell’ovest, estese al di là del passo dove, si narrava, transitò l’eroe semidivino Ercole nel suo lungo viaggio verso i mitici Giardini del Tramonto; laggiù dove avrebbe trovato la finis terrae, i confini più occidentali del mondo, il regno dell’eterno tramonto al cospetto del mare sconfinato.
Lythia assomigliava molto al padre, sia nell’aspetto che nell’indole. Ma se per quanto riguardava l’aspetto senza dubbio Catumaro ne andava fiero ed era certo che quella vivace pargoletta sarebbe diventata una splendida fanciulla, facile da maritare con un importante principe, magari di qualche potente tribù del nord, ugualmente era molto preoccupato da quel carattere testardo, cocciuto e dalla spiccata voglia di indipendenza.
Lythia era una bimba dalla brillante intelligenza, molto intuitiva, capiva al volo il significato di discorsi anche difficili per la sua età, capiva le situazioni e, come la nonna, “sentiva”… In più era assai curiosa e non appena riusciva a sfuggire al controllo di qualche adulto, si inerpicava sù per i sentieri che dalla piana conducevano verso i villaggi e, da lì, verso le terre alte. In particolare era letteralmente affascinata dalle stelle e poteva passare ore a guardarle. Infatti occorreva prestare molta attenzione perché durante la notte, la bimba non ci pensava due volte a scappare di casa per andare ad osservare gli astri, sempre alla ricerca della Grande Orsa e di una strana stella a forma di “A” non troppo distante da uno strano corpo luminoso a forma di spirale.

Catumaro si incupiva ogni volta che la piccola gli raccontava di queste sue passioni; non amava affatto che sua madre Licamara le riempisse la testa con queste antiche storie di popoli perduti osservatori delle stelle né che la istruisse nel sapere druidico. Troppo pericoloso. Catumaro cercava in ogni modo di troncare le passioni della figlia, ma così facendo, otteneva l’effetto contrario. La piccola Lythia pendeva letteralmente dalle labbra della nonna-maestra, nonna guaritrice dalla quale in molti si recavano per ottenere medicamenti e rimedi, nonna-veggente che sapeva leggere i segni della natura, del cielo, del fuoco.
E la nonna, da parte sua, aveva capito fin dai primi vagiti che Lythia era una predestinata; a lei un giorno avrebbe potuto rivelare il grande segreto di pietra. Un segreto che racchiudeva la storia del suo popolo e che anche a lei era stato tramandato da sua nonna secondo una linea matriarcale che si perdeva nella notte dei tempi.
Anche quel giorno Lythia, dopo aver bevuto avidamente la sua ciotola di latte, si precipitò in classe. Nonna Licamara stava appendendo dei grandi disegni alle pareti per aiutare i piccoli a seguirla nei suoi discorsi.
Lythia riconobbe subito il simbolo della grande spirale. “Nonna! La spirale del cielo! Purtroppo sono settimane che non riesco ad uscire la notte… mio padre blocca la porta dall’esterno e ha addirittura messo un suo servitore a fare la guardia intorno a casa…”. La nonna sapeva dell’avversione del figlio per quel genere di conoscenza. Sapeva che secondo Catumaro solo gli uomini potevano dedicarsi alla scienza druidica e che mai avrebbe voluto istruire la figlia in tal senso. “Non preoccuparti Lythia”, la tranquillizzò, “tanto siamo solo a metà aprile; la vedrai ancora meglio mano a mano che ci avviciniamo all’estate”.
“E questa? Ricordi cos’è?”. “Certo!”, esultò Lythia, “è la grande A. E’ l’aratro del cielo!”.

“Bravissima”, rispose la nonna, “è la costellazione che i popoli del mare chiamano Andromeda, col nome di un’importante principessa. Ma io preferisco continuare a vedervi un aratro. L’aratro che solca la terra, la rompe e la prepara ad accogliere il seme. Sai, piccola mia, vi fu un tempo in cui i nostri antenati, in certi precisi momenti dell’anno, aravano il terreno per motivi diversi da quelli agricoli che conosciamo noi. I buoi con le corna più belle, i più possenti ed imponenti, simbolo di forza e vigore, venivano aggiogati e condotti avanti e indietro trascinando un vomere sacro. Era come una sorta di preghiera affinché gli dei della terra fossero compiacenti. Ma non solo per avere un florido ed abbondante raccolto, anche per proteggere la comunità, il popolo. Quella terra doveva dare il cibo, doveva nutrire forti e valorose stirpi di guerrieri e di donne capaci di generare molti figli per dare continuità al popolo”.
Lythia ascoltava rapita. “E quindi facevano la fatica di arare un campo intero… solo per pregare, nonna?!”. “Come SOLO?!”, sbottò Licamara; “è assai importante che gli dei siano benevoli, piccola, altrimenti il popolo è destinato alla rovina!”. “Vedi anche ora? Non ti accorgi che nonostante le apparenze, la nostra comunità si sta sfaldando? Altri clan potenti nutrono invidia verso tuo padre e tramano nell’ombra. Ultimamente molte, troppe, donne vengono da me piangendo perché non riescono a generare figli e questo crea attriti in seno alla famiglia e al clan. Sempre più spesso vengono a chiedermi rimedi per le mucche che producono poco latte e iniziano a non sopravvivere al parto, oppure generano vitelli deformi o già morti! Dobbiamo stare attenti, Lythia! Gli dei ci stanno avvertendo. Qualcosa va cambiato… ma tuo padre non mi ascolta. Tuo padre rifiuta la saggezza del primitivo femminile…ahimé…e il grande druido continua a rassicurarlo, ma solo per fare i suoi interessi!”.
“Ma, nonna, sei sicura? A me sembra che qui nel grande villaggio di Carnobriga si viva bene. Io sono felice!…”. “Sei ancora piccola, Lythia; e va bene così. Arriverà il tempo per capire e per reagire. Arriverà il tempo per dare, anche tu, il tuo contributo alla comunità. Ma adesso stanno arrivando i tuoi compagni: è ora di fare lezione. Vai a sederti, sù!”.

Passavano i giorni, i mesi, le stagioni. La piccola Lythia cresceva a vista d’occhio, in altezza e in intelletto. Ma anche in intuito. Lei, come da sempre sosteneva la vecchia e saggia nonna Licamara, aveva la capacità di “sentire”. Aveva iniziato ad accorgersi di un fatto strano: quando passava vicino a certe rocce, sentiva come un brivido che le percorreva la schiena, come un sussurro lontano, una voce imperscrutabile, indecifrabile, che la chiamava e le chiedeva di fermarsi. Allora Lythia si fermava e quasi istintivamente toccava una roccia, ma non una roccia a caso, di solito erano rocce grandi e lisce che fuoriuscivano dal terreno. Non appena la sua mano sfiorava la superficie, Lythia era percorsa da tremori e aveva come delle visioni. Ma la sua ancora giovane età le impediva di capirle, di descriverle. Provava a raccontare alla nonna ciò che, a tratti, vedeva; la nonna capiva e cercava di darle supporto e consiglio. Guai a farne parola col padre, tuttavia!
Lythia aveva compiuto ormai 15 anni. Il grande villaggio di Carnobriga era scosso da frequenti tumulti interni. I clan erano in subbuglio. Spesso si svolgevano grandi riunioni coi capi delle tribù delle terre alte, quelle che vivevano nei villaggi fortificati, costruiti come fossero un’unica fortezza rocciosa a ridosso delle morene o nelle gole più nascoste. Si diceva che dalla pianura il pericolo fosse ormai vicino. Un popolo venuto da molto lontano stava premendo per impossessarsi delle terre alte, per controllare quei valichi che erano stati loro sin dai tempi più remoti. Bisognava intervenire, ma come? I clan erano sempre in lite e Catumaro non riusciva più ad imporsi sugli altri come una volta. Anche perché il popolo non era unito per fronteggiare al meglio questo oscuro “nemico”; infatti c’era chi ventilava possibilità di guadagno dalla collaborazione con queste genti straniere.
Nonna Licamara sospirava. Se lo aspettava. Sapeva che prima o poi si sarebbe arrivati a questo. Il popolo stava vacillando e di Carnobriga forse si sarebbe persa memoria…
“Nonna, ma mi spieghi come mai mio padre si ostina a non darti ascolto? E perché, anche adesso che la Grande Dea mi ha reso donna, tenta di impedirmi di trascorrere tempo con te?”.
“Vedi Lythia, tuo padre ha un rapporto problematico con se stesso, col suo passato… Sai, ora che hai 15 anni posso parlartene. In realtà lui non è mio figlio naturale. Lui fu messo al mondo da una donna importante: era una sacerdotessa del nord. Purtroppo si innamorò e questo non avrebbe dovuto succedere. In più, come se non bastasse, si innamorò di un giovane, bellissimo guerriero straniero. Suo padre, una volta saputo della sua gravidanza che non si poteva più nascondere, non solo la cacciò di casa ma fece uccidere il suo amato. Io la accolsi nel mio villaggio. Pur se ancora giovane, ero già una nota guaritrice e mio padre era il capo villaggio, un uomo di cuore e di fine intelligenza che portava grande rispetto verso le mie qualità. La aiutai a partorire; ma lei, ahimé, non sopravvisse a quel parto difficile. Perse molto, troppo sangue. Provai in ogni modo, ma non riuscii a salvarla. Solo, con l’ultimo respiro che le restava in corpo, appena prima di morire, mi raccomandò quel frugolino urlante dai folti capelli neri e mi mise in mano un amuleto cui lei teneva moltissimo”.

Licamara infilò una mano nelle vesti, all’altezza del seno, e ne estrasse un monile in bronzo lavorato a spirale; anzi, una doppia spirale! Era un oggetto molto bello, di colore verde scuro con riflessi blu, lucidissimo. Emanava un fascino ipnotico.
Lythia non aveva perso nemmeno una parola; era sgomenta, ma finalmente dava una risposta a molti atteggiamenti di suo padre. “L’ho cresciuto come fosse figlio mio. E mio padre da subito lo ha presentato al popolo come fosse suo nipote naturale. Quando raggiunse l’età adulta gli tatuammo la doppia spirale sul petto, affinché gli dei di sua madre vegliassero su di lui, ma senza dirgli la verità. Purtroppo la venne a sapere l’anno seguente, e nel peggiore dei modi, da un compagno d’armi, principe di un clan rivale, che gliela rivelò per invidia e per dispetto dandogli dell’illegittimo, per non ripetere altre offese ben peggiori che sporcavano persino il ricordo di sua madre”.
“ Da quel momento il suo atteggiamento verso di me cambiò radicalmente. Era come se non mi accettasse più. Sicuramente vede in te la sua vera madre e, in tutta sincerità, le somigli moltissimo. I lunghi capelli scuri, i grandi occhi verdi, la mandibola volitiva. Lui ti teme, Lythia. E teme per la tua vita.”
Lythia era scossa ed emozionata. Avrebbe voluto correre da suo padre ed abbracciarlo, rincuorarlo… ma ultimamente anche il rapporto tra di loro si stava logorando per i troppi litigi, le incomprensioni, le cose non dette o mal dette.
“Ma, nonna, io però non ho mai visto la doppia spirale tatuata… Lui sul petto ha dei simboli vegetali che non mi ha mai voluto spiegare…”. “No, Lythia. Sotto quei simboli c’è la doppia spirale. Lui se l’è fatta cancellare apposta, per non vedersela addosso. Il fatto è che quella doppia spirale lui ce l’ha dentro, nell’anima; è la voce dei suoi antenati. E non può continuare a rinnegarla e a tenerla sepolta. Presto riemergerà.”
Lythia tornò a casa con la mente in preda a mille pensieri. Chi era la sua vera nonna? Quali doni le aveva passato? Cosa cercavano di dirle quelle strane pietre lisce che ogni tanto vedeva sbucare dal suolo?
Doveva capire. Sentiva che se avesse capito, avrebbe potuto aiutare non solo suo padre, ma tutta la sua gente.
Trascorsero altri due anni. Anni di studio, di formazione continua con nonna Licamara. Il padre, talmente spossato dalle lotte intestine tra clan, non aveva nemmeno più tempo né forza di star dietro a sua figlia. Sua madre, donna timida e riservata, si era chiusa in un silenzio preoccupante che la stava avvelenando dentro. Il popolo era scontento, agitato, ribelle e allergico a qualsiasi regola.
Il sapere dei padri si stava perdendo, qualcuno addirittura lo rinnegava e lo travisava; alcuni persino lo mettevano in ridicolo. E infatti la natura aveva cominciato a ribellarsi. Il grande fiume Druantia si gonfiava ad ogni autunno; diventava incontrollabile con terribili e rovinose esondazioni. L’altro grande fiume della piana, quello che scendeva da nord, il Bauthegion, causava danni nefasti ogni estate. Coltivare era diventato quasi impossibile. I pascoli si erano impoveriti per le temperature sempre più rigide, le frequenti grandinate, le gelate improvvise. Gli animali erano in sofferenza, persino le pecore e le capre, solitamente così robuste.
Intanto nonna Licamara era sempre più debole; gli anni sulle sue spalle erano davvero tanti. Finché una notte fece chiamare Lythia.
“Vieni piccola mia, avvicinati. Non mi resta più molto tempo e devo assolutamente parlarti. E’ giunto il tempo, il tuo”. Lythia si avvicinò il più possibile; la voce della nonna era talmente flebile che a stento la udiva. “ Vedi, Lythia, tu sin dalla nascita sei destinata ad essere la custode di un grande sapere. Ad essere la custode dell’identità e del passato di un grande popolo. Il popolo che, giunto al seguito del semidio Ercole in un tempo remoto e perduto, decise di fermarsi qui, ai piedi delle grandi montagne. Queste montagne accolsero quelle genti e divennero la loro casa. Quelle genti giunte dalle lontane terre d’Oriente, dal regno dell’eterna Aurora, conoscevano l’arte di osservare il cielo, le stelle, il moto degli astri e le fasi della Luna. Sapevano come coltivare la terra e renderla fertile. Conoscevano l’uso dell’aratro, strumento fondamentale che diede la forma alla costellazione della grande A che tu conosci sin da bambina”.
Ogni tanto la nonna veniva scossa da forti e dolorosi crampi; spesso le mancava il fiato ed era ricoperta di sudori freddi. Lythia era molto preoccupata. La abbracciava. Le passava un panno fresco sulla fronte cercando di darle sollievo.
“ Quel popolo, Lythia, scelse questa pianura nei pressi del fiume Druantia. Una pianura che venne arata, ma non per seminare, per pregare, come ti avevo già spiegato. Al centro di questa pianura si elevava un collina, il nucleo del nostro villaggio: Carnobriga, che in lingua gallica significa “altura delle corna”, un villaggio posto sotto la protezione del dio Cernunnos, signore delle forze naturali e del vigore guerriero.
Dopo il tempo delle grandi arature propiziatorie, venne il tempo delle grandi fosse. La terra era fondamentale, era dea, era madre, era nutrice. La terra esigeva preghiere e devozione e gli uomini sapevano come accontentarla.
Venne poi il tempo in cui il cielo si unì alla terra, anche nelle preghiere. Ed ecco che i nostri antenati eressero pali verso le stelle, assecondandone gli allineamenti ed i segni affinché le divinità celesti fossero benigne. Tuttavia l’attenzione data al cielo iniziava a sminuire quella destinata alla Terra. La Grande Madre si stava offendendo. La linea matriarcale cominciò a contare sempre meno. I villaggi erano dominati dagli uomini, purtroppo non tutti saggi e avveduti. Purtroppo il potere acceca e gli antichi equilibri sacri si sfrangiano.
“Ma, quando? Quando successe tutto ciò? E dove si trova questo luogo? Dove sono queste fosse, questi pali….”. Lythia era divorata dalla curiosità; voleva sapere, sentiva che doveva sapere.
La nonna appoggiò debolmente una mano sul braccio della nipote. “Presto lo saprai, cara. Dovrai cercare, ma senza allontanarti”. Lythia la guardava interrogativa. Licamara prese quindi la mano sinistra di Lythia, la mano del cuore, e la guidò tra le vesti, madide di sudore, fino a toccare la pelle avvizzita del petto. Aperte le vesti, mostrò a Lythia un tatuaggio: la doppia spirale. Anche nonna Licamara l’aveva, proprio sul petto.
“E’ un legame, cara. E’ un simbolo capace di unire terra e cielo. Capace di dare la vita, anche oltre la morte. E’ il flusso eterno, Lythia. E’ il moto delle stelle e dei corpi celesti. Questo simbolo è il segreto della forza del nostro popolo che, nonostante il volgere dei secoli e degli avvenimenti, saprà trasformarsi e sopravvivere. Ma che ora ha bisogno di ritrovare se stesso.”
L’anziana mise infine nelle mani di Lythia l’antico amuleto regalatole dalla madre di Catumaro. “Cercala! Cerca la doppia spirale incisa nella grande pietra, Lythia. Puoi farcela!”. “Ma come? Nonna, nonna!! Ti prego, dimmi come devo fare… dove, devo cercare?…Nonna…”. Ma ormai la vecchia Licamara, era salpata verso il regno delle Ombre senza fine.
Per alcuni giorni Lythia rimase preda del dolore per questa atroce perdita. Sua nonna non c’era più; era stata da sempre la sua guida, il suo sostegno, il suo punto di riferimento…come avrebbe fatto senza i suoi consigli e i suoi preziosi insegnamenti?
Alla fine, colma di lacrime fino a scoppiare, corse dal padre per sfogare su di lui tutta la sua rabbia da troppo tempo repressa. “Tu! Tu hai lentamente portato la nonna alla morte! Tu, perfido uomo, col tuo atteggiamento ostile, con la tua cattiveria… maledetto! Come hai potuto non esserle vicino nemmeno alla fine?! Tutto preso dai tuoi giochetti politici, dagli equilibri tra i clan, circondato come sei di traditori e adulatori…. Senza neppure accorgertene!”.
Lythia si scagliò sul padre, tempestandolo di pugni e di lacrime… finché il padre, prima immobile, all’improvviso la strinse a sé con forza. Lythia si accorse che stava piangendo. Suo padre, il prode Catumaro, che piangeva? “Padre….”, sussurrò. “Oh Lythia, figlia mia adorata. Saggia figlia mia. Non ti ho mai meritato. Più crescevi e più vedevo in te mia madre; nemmeno riuscivo a guardarti negli occhi. Mi facevi paura. Mi incutevi rispetto. E questo mi dava fastidio, spesso tu stessa mi sei sembrata una minaccia della mia autorità, della mia supremazia. E invece avevi ragione, l’hai sempre avuta. E Licamara aveva visto giusto, come sempre del resto. Aiutami, Lythia! Sento che sto per soccombere…”
“Padre, ma perché non avete mai voluto parlarmi prima? Perché avete sempre cercato di seppellire i vostri ricordi facendovi solo del male? Facendo del male anche a mia madre, vostra sposa, e a vostra madre, anzi, alle vostre due madri!”. Lythia mostrò l’amuleto al padre. “Ecco, questo è il segreto della nostra forza! Dobbiamo trovare questo simbolo inciso nella pietra da qualche parte qui intorno a Carnobriga! Se non lo facciamo, la nostra gente scomparirà divorata dagli eventi e dai secoli finché se ne perderà persino la memoria, la condanna peggiore che ci possa essere!”.
Catumaro sgranò gli occhi… quanto tempo era passato dall’ultima volta che aveva visto quel simbolo? E come aveva potuto farsi nascondere il tatuaggio? Forse proprio da quell’insano gesto era iniziata la sua rovina… chissà se c’era ancora modo di arrestare questa caduta e dare nuova forza alla sua famiglia, al suo clan, al popolo intero!
“Sono nelle tue mani, Lythia. Agisci come meglio ritieni. Agisci ascoltandoti, tu che ne sei capace”.
Dopo un ultimo abbraccio che però valeva come tutti quelli che mai si erano dati negli ultimi 5 anni, Lythia uscì. Era notte fonda. Si incamminò, alla luce di una sottile falce di luna, verso un luogo a lei caro da cui si dominava l’intero fondovalle. Una volta arrivata, si appoggiò l’amuleto sul petto e, con gli occhi al cielo, intonò antiche nenie insegnatele dalla nonna.
All’improvviso le parve che il cielo stellato iniziasse a girare, sempre più veloce, formando un’enorme spirale di stelle e polveri brillanti. Sopraffatta da quella luce fortissima (che solo lei vedeva) chiuse gli occhi; ebbe una visione. La spirale si sdoppiò e al centro ne uscì una grande A che si rivelò per quello che era in realtà: un aratro.
L’aratro iniziò a solcare la volta celeste che, al suo passaggio si apriva. Dai solchi tra le stelle emersero delle grandi pietre. Talmente grandi come non ne aveva mai viste. Pietre con occhi e naso, ma mute, senza bocca. Pietre ricoperte di simboli, di monili, di armi. Ed eccone una che colpì la sua attenzione: indossava un amuleto. La doppia spirale. Inizialmente le sembrò che fosse un gioiello, poi vide che emanava luce ma che in realtà era incisa nella pietra.
Aprì subito gli occhi, spossata. Tutt’intorno a lei, il silenzio della notte. Guardò nuovamente il cielo e stavolta seppe leggere segni che prima non avrebbe mai capito. Seguì una sorta di sentiero disegnato nel cielo che la guidò nuovamente a valle. Gli astri indicavano un punto in cui lei sentiva che doveva fermarsi.
Si accorse di essere appena ad ovest di Carnobriga, ai margini del villaggio, lì dove già da secoli ormai era loro usanza seppellire i morti. Ma lei ne aveva paura. Era la zona dei grandi tumuli di pietra, delle tombe giganti e delle grandi pietre. Ma era la terra destinata ai morti, e lei non avrebbe mai osato addentrarvisi. Una necropoli che i suoi concittadini stavano oltretutto lentamente abbandonando perché ormai satura; qualcuno addirittura diceva fosse maledetta da qualche sortilegio. Fu il grande druido a mettere in giro questa voce. In realtà voleva venissero dimenticati i sacerdoti che lo avevano preceduto; voleva infangarne la memoria inducendo il popolo a trovare un altro posto per i defunti.

La luce delle stelle pareva illuminare un punto in particolare. Lythia si avvicinò, si chinò a terra appoggiando le mani su uno spigolo di pietra lucida e liscia, di forma tondeggiante. Udì un sospiro, un sussurro che usciva dalle viscere del terreno. Venne travolta da una sorta di sonno.
Ecco, un’altra visione! Vide che sotto di lei, nelle viscere della terra, giaceva una grande pietra al cui centro, come fosse sul petto, brillava il simbolo della doppia spirale. Gli antenati delle grandi tombe erano offesi per essere stati dimenticati. Gli spiriti erano inquieti. Capì.
Si precipitò da suo padre e gli spiegò l’accaduto. Questa volta Catumaro le credette e la assecondò. Allontanò malamente il druido adulatore e bugiardo e obbedì alla figlia.
Coi saggi, gli anziani e i nobili guerrieri del villaggio, si recarono in processione, la notte stessa, alla luce delle torce, fino all’antica necropoli. Lì dove i loro antenati avevano eretto tombe giganti sul terreno delle grandi pietre senza volto e senza nome.

Grandi pietre non riconosciute che vennero abbattute ed utilizzate come materiale da costruzione. Gli spiriti delle grandi pietre erano offesi. E così pure le anime dei defunti delle grandi tombe. La trascuratezza e l’indifferenza degli uomini, dei loro stessi eredi, ne aveva suscitato le ire. Questo aveva portato al ribellarsi della natura e alle lotte tra gli uomini, tra fratelli dello stesso sangue, incapaci di stare saldi ed uniti.

Solo restituendo valore alla memoria degli antichi, gli spiriti si sarebbero placati. Lythia individuò un punto particolare sul terreno. Chiese che venisse scavata una fossa; vi gettò semi e frutti (secondo antiche usanze spiegatele dalla nonna), recitò antiche preghiere di una lingua perduta e dimenticata dai più, vi gettò persino un tizzone infuocato che presto si spense. Alla fine vi seppellì la doppia spirale di metallo verde: l’amuleto di nonna Licamara era tornato da dove era venuto. Gli spiriti, così, ritrovarono pace. Il popolo riprese a frequentare quell’area e a seppellirvi i suoi cari. Un’usanza che sarebbe diventata abitudine. Altri popoli, nei secoli che seguirono, continuarono ad utilizzare questa zona sacra per dare degna sepoltura ai loro defunti. La terra torno fertile, la natura amica e madre. I lavori agricoli ripresero come da tempo non era possibile. I clan ritrovarono l’armonia.

Non poteva sapere la giovane Lythia che dopo altre decine di secoli, dopo il volgere di centinaia di stagioni, di albe e di tramonti, di giornate di sole e di cieli stellati, la voce di quell’amuleto si sarebbe fatta di nuovo sentire, ma questa volta non dai sacerdoti o dai druidi, ma dai ricercatori del tempo.
A distanza di quasi 1.500 anni da quando visse Lythia, la terra delle grandi pietre è tornata alla luce. Solo un tassello ancora manca: nessuno ha mai più ritrovato l’amuleto a doppia spirale. Forse, chissà, giace ancora sepolto lì, da qualche parte tra le grandi tombe e le immense stele a forma d’uomo.
Chissà se mai qualcuno riuscirà a ritrovarlo.
Oppure, chissà, forse è più giusto che nessuno lo ritrovi mai.
Stella


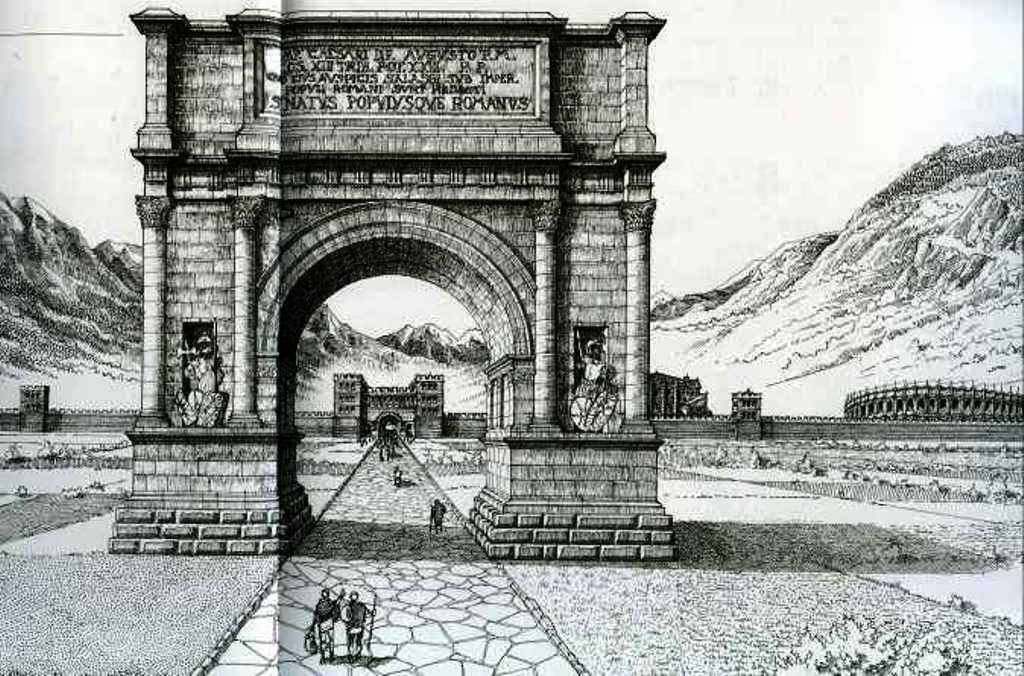

















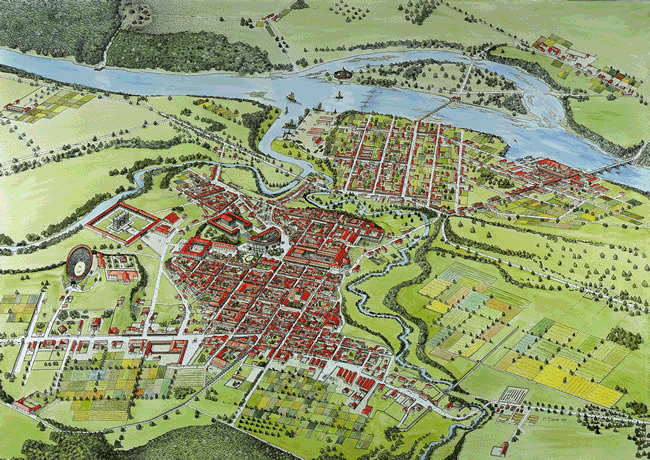

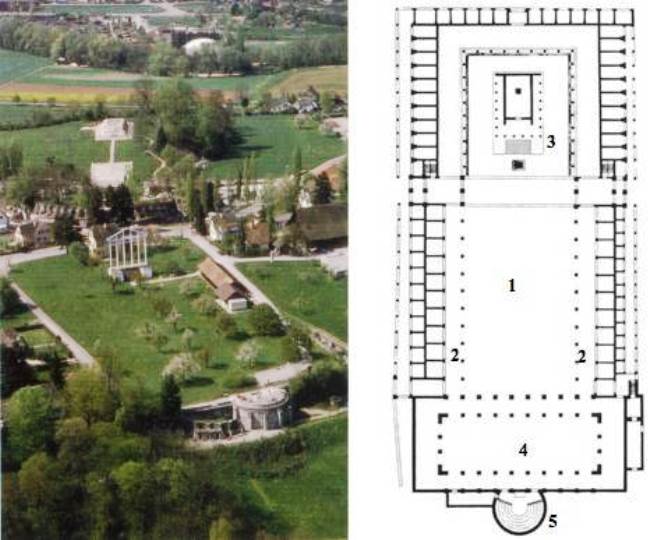

















 Lui più alto, secco, severo seppur, in fondo, buono di animo. Lei, più piccina (ma non troppo)… dipende da come li guardi (e spesso è così anche nelle coppie “umane”!), dai fianchi larghi e dal seno prosperoso. Emilius e Becca, quasi fossero gli antenati, i rocciosi genitori di questa piana verdeggiante solcata dal nastro della Baltea Dora.
Lui più alto, secco, severo seppur, in fondo, buono di animo. Lei, più piccina (ma non troppo)… dipende da come li guardi (e spesso è così anche nelle coppie “umane”!), dai fianchi larghi e dal seno prosperoso. Emilius e Becca, quasi fossero gli antenati, i rocciosi genitori di questa piana verdeggiante solcata dal nastro della Baltea Dora.
































 Quel che permane, in ogni narrazione, tempo e cultura, è il concetto che le Sirene richiamano e che giunge sino a noi: quello dell’ambiguità, della doppiezza – che è anche nella loro coda – parte integrante del loro fascino misterioso da Dark Ladies; quasi due facce della stessa medaglia: benevole, dolci, seducenti, quanto malevole, ingannatrici, addirittura crudeli, sicuramente sfuggenti!
Quel che permane, in ogni narrazione, tempo e cultura, è il concetto che le Sirene richiamano e che giunge sino a noi: quello dell’ambiguità, della doppiezza – che è anche nella loro coda – parte integrante del loro fascino misterioso da Dark Ladies; quasi due facce della stessa medaglia: benevole, dolci, seducenti, quanto malevole, ingannatrici, addirittura crudeli, sicuramente sfuggenti!




 … alla più disincantata e maliziosa sirena Marina della serie “Zig & Sharko”, bramata dagli “appetiti” dell’insaziabile iena Zig e amata dal romantico e nerboruto squalo Sharko, il cui idolo è il bagnino David Hasseloff di Baywatch!
… alla più disincantata e maliziosa sirena Marina della serie “Zig & Sharko”, bramata dagli “appetiti” dell’insaziabile iena Zig e amata dal romantico e nerboruto squalo Sharko, il cui idolo è il bagnino David Hasseloff di Baywatch!